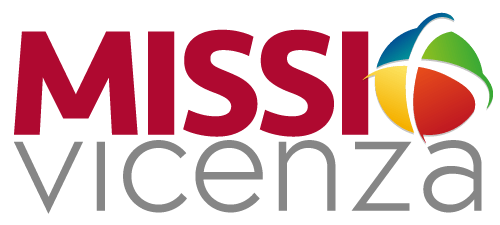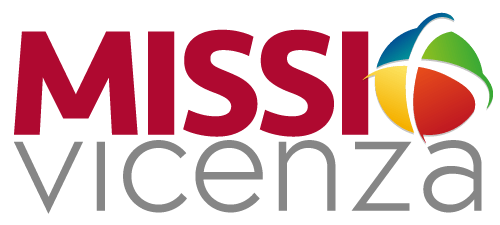Il 5 ottobre di vent’anni fa veniva uccisa Annalena Tonelli. Ancora oggi molte sue attività continuano a dare frutto nel luogo in cui era cominciata la sua missione africana: a Wajir, nel deserto del Kenya, dove tanti si ricordano di lei e del suo straordinario impegno.
«Partii decisa a gridare il Vangelo con la vita sulla scia di Charles de Foucauld, che aveva infiammato la mia esistenza». Partì alla volta del deserto del Kenya, Annalena Tonelli: scelse Wajir, luogo poverissimo e abbandonato, nell’Est del Paese, abitato da pastori somali musulmani. «Credevo di non potermi donare completamente rimanendo nel mio Paese. I confini della mia azione mi sembravano così stretti, asfittici… Compresi presto che si può servire e amare dovunque, ma ormai ero in Africa e sentii che era Dio che mi ci aveva portata e lì rimasi nella gioia e nella gratitudine», dirà molto tempo dopo, in una rara testimonianza pubblica, poco prima di essere uccisa il 5 ottobre 2003 a Borama, in Somaliland, dove aveva trascorso l’ultimo periodo della sua vita.
A vent’anni da quel terribile omicidio, la testimonianza di Annalena, il suo amore per gli ultimi, la sua dedizione ai malati e disabili, la sua passione per l’umanità ferita e per le donne discriminate continuano a dare frutti proprio là dove tutto era cominciato: in questo angolo del Kenya che è tuttora poverissimo, che è afflitto da una terribile siccità che dura da diversi anni, e ferito da instabilità e insicurezza provocate dai terroristi Al Shabaab che si infiltrano dalla vicina Somalia. Eppure proprio qui, in questo angolo remoto di Africa, tante realtà e tante persone continuano a raccontare di Annalena, non come qualcosa che appartiene al passato, ma come una memoria viva, una testimonianza di vicinanza agli ultimi che si rinnova attraverso le persone che l’hanno conosciuta e hanno beneficiato del suo aiuto, e attraverso chi sta portando avanti le sue opere.
Sono innanzitutto le suore camilliane keniane che rendono viva e attuale questa memoria. Abitano nella casa che venne fatta costruire da Annalena e continuano il suo lavoro nel Centro di riabilitazione e nel dispensario. Al di là della strada c’è la TB Manyatta, il Centro antitubercolare per cui Annalena si era spesa moltissimo, arrivando a mettere a punto un protocollo riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) specificamente abbreviato per andare incontro alle esigenze dei pastori nomadi. E poi c’è la scuola per sordomuti, diretta da una sua “figlia”, Qali Mohamed, che oggi tra molte difficoltà porta avanti con tenacia una realtà che permette a più di 200 ragazzi e ragazze disabili di studiare… Ci sono tutti questi segni concreti a Wajir, che continuano a raccontare di una presenza fecondissima, di un lavoro monumentale realizzato da Annalena con le sue compagne sino al 1985 quando venne espulsa per aver denunciato il massacro delle popolazioni di Wagalla.
Ma c’è un luogo che più di altri racconta non solo della sua straordinaria capacità di “fare”, ma del suo più profondo modo di essere: l’eremo che Annalena ha fatto realizzare sul vasto terreno che le fu regalato dalle autorità locali. Un luogo di solitudine, di silenzio e di preghiera, dove ritrovare «equilibrio, quiete, lungimiranza, saggezza, speranza, forza per combattere la battaglia di ogni giorno prima di tutto con ciò che ci tiene schiavi dentro, che ci tiene nel buio», scrive Annalena, che, sin da giovanissima, è ben cosciente che la prima e principale lotta è quella contro le proprie miserie e la prima e principale forza per affrontarla è quella spirituale. E proprio in questo luogo, su quella che lei stessa definisce «la sabbia del deserto più amato del mondo», sono state disperse le sue ceneri. C’è una piccola lapide su un muro con una frase di Isaia: «Il deserto si rallegrerà e fiorirà». Mentre al centro del cortile c’è un pozzo. «È l’unico che non si è disseccato – ci fa notare suor Rosemary – forse perché qui c’è Annalena». Suor Rosemary è la superiora della comunità di religiose camilliane che vivono nella casa di Annalena. «Quando ci hanno proposto di venire a Wajir abbiamo scelto, secondo il nostro carisma, di occuparci soprattutto delle iniziative in campo sanitario. È un onore e una responsabilità, per noi, farlo nel solco di Annalena».
Il Centro di riabilitazione, in particolare, è ancora oggi un servizio unico e prezioso per i poliomielitici e i disabili fisici e mentali di Wajir e dei dintorni. Tutte le mattine, l’auto delle suore li raccoglie nelle capannucce in cui vivono ai margini della città o nei villaggetti sparsi nel deserto. È stata una grande battaglia di Annalena, nel corso di tutta la sua vita, dare cure e dignità a persone che spesso venivano abbandonate perché colpite dallo stigma e dalla vergogna oltre che dalla malattia.
«Alla fine, io sono veramente capace solo di lavare i piedi in tutti i sensi ai derelitti, a quelli che nessuno ama, a quelli che misteriosamente non hanno nulla di attraente in nessun senso agli occhi di nessuno – diceva Annalena -. E se prima era un desiderio più umano, poi Dio è entrato in maniera fortissima nel mio progetto di vita. Altrimenti non ci sarebbe stata la forza di superare così tante prove».
Una di queste ha riguardato la battaglia – che è stata di tutta la sua vita e che è cominciata proprio a Wajir – contro la tubercolosi, una malattia che colpisce moltissimo i popoli somali, e che richiede tempi molto lunghi di cura. Originariamente la TB Manyatta, così come Annalena l’aveva realizzata, somigliava in tutto e per tutto ai villaggetti in cui vivevano le famiglie allargate, con capannucce individuali costruite con rami e paglia. Oggi le capanne sono state sostituite da casette in muratura e la gestione è passata al governo, ma il principio di cura rimane lo stesso.
Così come rimane la stessa l’attenzione per i sordomuti. Negli ultimi anni a Borama aveva fatto realizzare una scuola che era la migliore di tutta la Somalia e dove insegnavano due docenti che lei aveva formato proprio a Wajir. Uno di loro è tornato qui e insegna ora nella scuola diretta da Qali, una delle amatissime “figlie” di Annalena, che aveva preso con sé bambini e bambine provenienti da situazioni difficilissime e aveva dato loro la possibilità di studiare. «Mia madre era morta e mio padre era molto anziano. In casa non avevamo nulla. Annalena mi ha dato un futuro. È stato uno shock per me quando è stata espulsa. Ma siamo sempre rimaste legate e sono andata a trovarla quand’era in Somalia», racconta oggi Qali, che oltre alla scuola deve occuparsi anche dello studentato. «La situazione è molto difficile perché il governo non ha dato soldi per sette mesi e non abbiamo cibo per gli studenti. Le famiglie sono troppo povere per pagare e molti sono costretti anche a condividere un letto».
Noor invece Annalena non se la può ricordare. È nato poco dopo che lei è morta. Ma le deve la vita. Sua madre, infatti, era una “figlia” di Annalena. Dopo molti aborti spontanei, le aveva chiesto di raggiungerla a Borama per poterla seguire durante la gravidanza. È stata lei una delle prime testimoni del suo assassinio. Ma la sua storia, così come quella di Annalena, non sono storie di morte. Annalena vive in tutti quelli che l’hanno incontrata. E anche in chi l’ha conosciuta solo dopo la sua uccisione. Come Noor, il cui nome – non a caso – significa “luce”.
A cura di Anna Pozzi – Mondo e Missione | Ottobre 2023