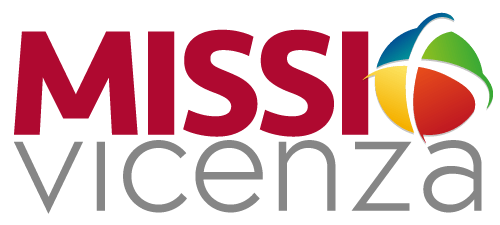L’arcivescovo di Torino spiega il tema che farà da filo conduttore al Festival della Missione, in programma a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. «La Chiesa non può fare a meno di trasmettere Cristo. Ma solo la gratuità oggi è in grado di fare breccia nel cuore dell’uomo»
Mancano poche settimane ormai al Festival della Missione, l’evento che dal 29 settembre al 2 ottobre vedrà convergere a Milano il mondo missionario italiano. “Vivere per-dono“ è il tema che farà da filo conduttore alle giornate. Una definizione di missione che deve molto a monsignor Roberto Repole, teologo torinese, già presidente dell’Ati (l’associazione dei teologi italiani), che al dono come categoria privilegiata per rileggere la missione ha dedicato negli ultimi anni due libri – “La Chiesa e il suo dono“ (Queriniana 2019) e “Il dono dell’annuncio” (San Paolo 2021) – divenuti in fretta un punto di riferimento per la riflessione sull’evangelizzazione oggi. Nel febbraio scorso, inoltre, a 55 anni Repole è stato scelto da Papa Francesco come nuovo arcivescovo di Torino, la sua città. È dunque in questa duplice veste di teologo e di pastore che gli abbiamo chiesto di parlarci delle sfide che la missione pone oggi alla Chiesa italiana. «Nella cultura odierna – spiega monsignor Repole – aleggia la paura che la missione sia imparentata con la forza o addirittura con la violenza. Viviamo in un contesto molto sensibile alla libertà di ciascuno e si rischia di pensare che la missione sia ormai qualcosa di improponibile. Al contrario, invece, l’idea del “vivere per dono” penso possa sollecitarci a una nuova riflessione e forse anche a nuove pratiche che rispondono a queste paure. Perché la Chiesa non può fare a meno di trasmettere Cristo. Ma se vuole tenere conto della libertà delle persone ed essere conforme al Vangelo, la missione deve avere il volto di un dono gratuito, libero, offerto con fiducia all’altro».
Nuove pratiche della missione: quali?
«La missione, ormai, non è più solo quella ad gentes, verso i popoli lontani, ma deve svolgersi anche dentro questo nostro ambiente che formalmente ha ricevuto il Vangelo, ma ormai è in via di scristianizzazione. Ripartire dalla logica del dono ci aiuta in tutti i contesti, perché la gratuità è la quintessenza del Vangelo. Stando attenti a non tradirla».
In che senso?
«Guardiamoci dalla tentazione di legare a noi le persone. Anche l’offerta del Vangelo è gratuita, aperta alla libertà dell’altro. Che comprende la possibilità del rifiuto o dell’indifferenza».
Lei indica l’ospitalità come una parola chiave della missione.
«Quando offre il Vangelo la Chiesa non fa altro che dire: c’è un posto per te in Dio. Ma l’ospitalità è un movimento in due direzioni: si apre uno spazio in chi fa il dono, ma anche in chi lo riceve. Da questo punto di vista l’esperienza della missione ad gentes ci dice che – laddove si è realizzata davvero – la Chiesa ha offerto il Vangelo, ma insieme si è scoperta nuova. Grazie al fatto di essere accolta si è ritrovata più ricca, sviluppando aspetti che prima non c’erano».
Vale anche per l’incontro con le altre religioni?
«Sì, quando la Chiesa dialoga senza mettere tra parentesi il Vangelo. Partendo dalla propria identità riceve dalle altre religioni la possibilità di cogliere nuove profondità della propria fede».
Da qualche mese il Papa l’ha chiamata a guidare una grande arcidiocesi italiana: che cos’è la missione oggi per Torino?
«La vedo come la possibilità di prendere atto – lucidamente, ma anche in maniera serena – che la cristianità è finita: non possiamo più dare per scontato che essere torinesi voglia dire essere cristiani. Non è più così, eppure le nostre chiese sono ancora strutturate come se lo fosse. Dobbiamo ripensarci accettando questa realtà. Ma, insieme, dobbiamo tornare ad annunciare il Vangelo agli adulti e ai giovani in particolare. E lo stile del dono mi sembra l’unica via che abbiamo».
Nella prima lettera che ha inviato all’arcidiocesi lei ha parlato della necessità di una verifica sulle strutture che appesantiscono la vita delle nostre comunità.
«È un aspetto concreto di questo discorso: chiediamoci se queste strutture oggi ci aiutano a vivere il Vangelo e a trasmetterlo ad altri, o non diventano invece un ostacolo. Per curarle finiamo per essere travolti da problemi che ci distolgono dalla relazione con le persone che cristiane non sono. Proprio l’esperienza di chi viene dai Paesi di missione ci mostra che se ci alleggeriamo non è finita la Chiesa. Anzi in molti casi è più giovane e vitale della nostra».
Dove, al contrario, dovremmo esserci e invece non ci siamo?
«Penso all’ambito culturale: mi colpisce che quando risuonano parole che vengono dal Vangelo si avverte subito intorno una grande sete. La cultura dominante segnata dal relativismo, dal nichilismo, dalla mancanza di prospettive di alto respiro, genera solitudini e povertà di senso. Ma noi corriamo il rischio di non esserci. Non servono cose straordinarie: semplicemente renderci conto della forza delle parole del Vangelo. A patto che per noi siano autentiche, non annegate in una retorica che non dice più nulla».
Ma in un contesto come questo che valore ha il fatto che dall’Italia ci siano ancora persone che partono per andare ad annunciare il Vangelo agli estremi confini della Terra?
«In passato era il segno di Chiese solide, forti, che mandavano propri figli là dove il Vangelo non c’era. Oggi viviamo noi stessi in un contesto che chiede una nuova evangelizzazione. Ma chi parte ha un grande valore simbolico per tutti. Ci dice che se vogliamo tornare a offrire il Vangelo anche qui dobbiamo attrezzarci con la stessa radicalità di chi lascia tutto, partendo per un’avventura che per molti versi rimane un’incognita. E lo fa mettendo in conto anche il martirio, come abbiamo visto recentemente con la vita donata da suor Luisa Dell’Orto ad Haiti. Come cristiani non abbiamo più confidenza con l’idea che annunciare il Vangelo possa incontrare anche un rifiuto tale da portare alla morte. È un richiamo alla radicalità che ci fa annunciare il Vangelo anche in mezzo all’indifferenza di oggi».
Che cosa le piacerebbe che si portasse a casa da Milano chi parteciperà al Festival della Missione?
«L’idea che senza la missione e l’urgenza di trasmettere Gesù Cristo agli altri non può esserci la Chiesa. Ma anche la consapevolezza della necessità di ripensare che cosa significa annunciare il Vangelo qui e oggi. Facendo i conti fino in fondo con la cultura che viviamo e con il mondo in cui siamo immersi». MM
Fonte. Rivista Mondo e Missione n. agosto/settembre 2022. Articolo di Giorgio Bernardelli
Condividi sui social: