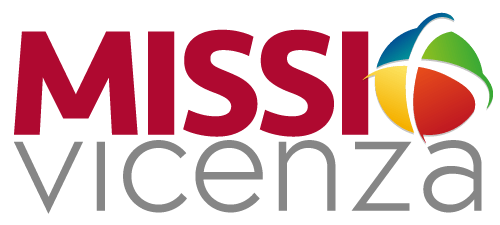Ci si casca spesso, anche come laici in missione, nel tranello che ci fa sentire superiori alle persone con le quali condividiamo un tratto di strada africana, latinoamericana o asiatica, verso la conoscenza del vangelo, semplicemente perché abbiamo frequentato scuole e svolto ben remunerate attività professionali e lavorative a loro inaccessibili. Al pari delle agenzie umanitarie internazionali che si occupano dell’aiuto ai cosiddetti “paesi poveri”, ci siamo arricchiti di parole dalla valenza quasi magica per descrivere le proprietà “terapeutiche” del nostro operare missionario, sfoggiando una corposa bibliografia legata a parole usate spesso come talismani per il benessere dell’umanità, che con il passare del tempo, però, perdono le loro proprietà taumaturgiche e vengono sostituite con altre espressioni più rispondenti alla moda del momento: una fra tutte, l’ormai mitica resilienza.
Anche il gergo “terzomondista” è in qualche modo utilizzato dai laici missionari per descrivere il loro operato, prendendo gradualmente atto della complessità contenuta in quelle parole chiave che conducono oggi ad una compiuta idea di sviluppo umano integrale (e sostenibile), magistralmente(!) descritto nelle encicliche di papa Francesco, Laudato sii e Fratelli tutti.
Più in generale, anche nel contesto missionario si è andato modificando il lessico, in origine legato essenzialmente al modo con cui veniva riportato il numero di battezzati e di chiese costruite, con l’immancabile corollario di aneddoti su incontri selvaggi: oggi non vi è realtà missionaria in cui non si coniughi esplicitamente l’evangelizzazione con la promozione umana avendo a cuore l’inculturazione del Vangelo.
In effetti, dobbiamo prendere atto che, proprio nei contesti missionari in cui la povertà è di casa, la Parola viene maggiormente vivificata da una lettura condivisa da persone spesso analfabete, ma dotate di profonda spiritualità, in grado di leggere ed interpretare in modo sapiente i “segni dei tempi”. Lasciare il giusto spazio alle sensibilità spirituali sulle quali si radicano le diverse culture è non solo un dovere etico di chiunque intenda instaurare una relazione rispettosa della dignità di ogni persona, ma è anche l’approccio più efficace da parte del missionario per poter testimoniare la universalità dei valori cristiani che intende trasmettere.
La inculturazione del Vangelo si fonda, quindi, essenzialmente sulla consapevolezza che non vi è una superiorità culturale precostituita e perfettamente conformata alla fede cristiana, con la quale “colonizzare” tutte le altre culture, ma richiede, invece, un costante impegno nel cercare, riconoscere e valorizzare le ricchezze proprie di ciascuna cultura per poterne esaltare anche il significato evangelico. In questa dinamicità di relazioni paritarie si inserisce in maniera specifica l’azione dei laici missionari con un proprio stile di evangelizzazione che, forse, non sempre mostra una linearità dottrinale, ma vi si possono comunque trovare i segni di una prossimità evangelica.
È pur vero, però, che i laici in missione non sono “cani sciolti”, ma devono giustamente rendersi partecipi e corresponsabili delle attività missionarie generalmente portate avanti in equipe, assieme ai preti fidei donum, ai religiosi e religiose, al personale pastorale locale, assumendo funzioni laicali esercitate sotto la guida del vescovo. Senza questa libertà obbediente risulterà difficile essere testimoni credibili e attraenti del vangelo.
E, in considerazione anche dalla recente istituzione del ministero del catechista, se da un lato il riconoscimento delle funzioni laicali come ministeri istituiti, anche e soprattutto, forse, in terra di missione, potrebbe indurre a qualche forma di clericalizzazione dei laici, dall’altro lato l’emersione formale delle ministerialità laicali accentua in modo graduale ma sempre più incisivo la “istituzionalizzazione” della presenza di laici e laiche all’interno della più ampia Istituzione ecclesiale.
Il «servizio in missione dei fedeli laici» (per usare un’espressione formale con cui viene identificato il “ministero” degli altrimenti conosciuti come laici missionari fidei donum), anche in questo tempo di pandemia ha saputo raggiungere i gradini più elevati della donazione di sé ai poveri, come nel caso di Nadia De Munari, missionaria laica, uccisa a Chimbote, in Perù, alla fine di aprile scorso ed ora ricordata come «martire della carità» dall’Operazione Mato Grosso, l’organizzazione di volontariato di cui faceva parte, e dalle tante persone che nella sua diocesi di provenienza, Vicenza, l’anno sostenuta negli oltre 25 anni trascorsi a portare segni speranza e di fraternità in particolare ai bambini più vulnerabili in quella parte di America Latina.
Sì, al di là dei facili slogan e parole convenzionali del momento, il “servizio in missione della fedele laica” Nadia è stato un esempio di quella dedizione totale ai poveri che è una chiave di accesso alla santità a cui ogni battezzato è chiamato.
A cura di Beppe Magri
Condividi sui social: